Una critica di Gaetano Mongelli
Gaetano Mongelli è uno storico dell’arte originario di Bari, noto per il suo contributo accademico e culturale nella regione. Ha ricoperto il ruolo di docente di Storia dell’Arte Moderna presso la Facoltà di Scienze Storiche dell’Università degli Studi di Bari.
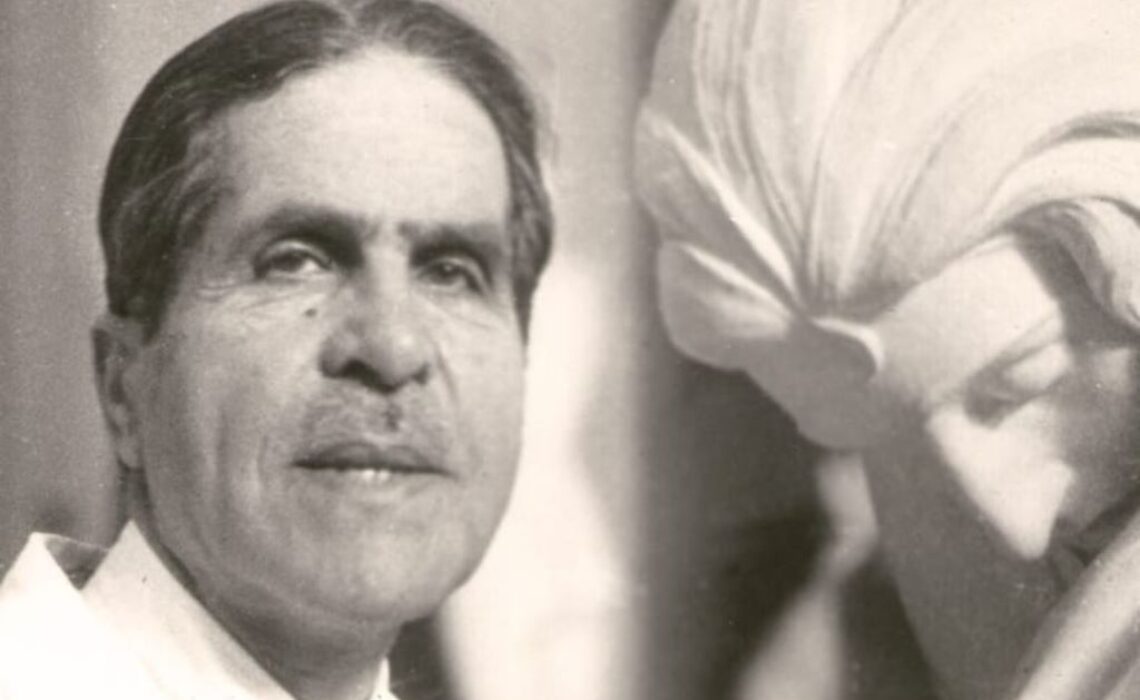
“Il Passato è un’opera d’arte, senza elementi incongrui né sbavature” (Beerbohm)
I pilastri su cui poggia la pittura di Giorgio Esposito trovano il loro fondamento granitico e inalienabile in un richiamo al Passato; un richiamo che ferma il tempo, ricco – com’è – di destino ed officiato con gesto liturgico rispetto al conformismo delle neo-avanguardie o, magari, dei relativi riciclaggi trasversali e comodamente omologabili.
Per Esposito l’Arte e la sua Storia non costituiscono – sotto qualunque voce si voglia configurare i due termini predetti – il trionfo del caso, ma del suo opposto; specie riandando alla buona pittura, per la quale “l’elemento decisivo, liberatorio […] è quello dell’allontanamento, della solitudine: disgusto istintivo per la vita cinerea, oscurata del presente”, giacché “è nella solitudine che nasce l’accordo fra anima occhio e mano di cui parlava Valéry”.
È un accordo che non trasfigura chi opera seriamente nel campo dei simulacri in un ammodato registratore epocale, ponendolo – su un versante differenziato – nella condizione di analizzare i segnali visibili di due crisi la cui soluzione non appare procrastinabile: il tramonto del fin troppo suffragato “modernismo” e l’interruzione definitiva del sentiero esaustivamente percorso dall’avanguardia. Sicché, per dar corpo appieno ad un simile programma, è necessario rientrare all’interno dell’arte e delle sue vicende, riepilogarne e capirne le intime connessioni, riscoprire – tra l’abiura e la non dimenticanza dei tempi più recenti – l’utilità e la consapevolezza estetica di un linguaggio perspicuo; un linguaggio, comunque, calato in realtà che non annulla, ma decanta prima e sublima dopo, ogni riflessione sull’esistenza e sulla storia, senza ammanettare al fusto della colonna infame del consumo la stessa fruizione delle immagini nella stesura allestitiva e metastorica della loro leggibilità.
Solo riattraversando come esplorazione sapienzale il terreno dell’arte si riguadagnano i contorni dell’essenzialità che insemina, per poi raccoglierne i frutti, il territorio dell’analisi del reale. Su tanto è doveroso perciò creare le debite distanze da Wilde quando ammette, per sopruso di aforismi, peraltro a lui cari che “il solo fascino del passato è il fatto che è passato”. Invece, il legame con l’antico innescato da Giorgio Esposito, mediante l’uso del simbolo, del mito e della introspezione, si cimenta alla consapevolezza di una risalita dopo lo smarrimento di una centralità che, senza marcare l’ordito del nostalgismo, mi capita sovente di aggettivare come adamantina e pierfrancescana, perché “di fronte alle tranquille ipotesi di utopie rivoluzionarie proposte in anni passati, la dichiarazione di fiducia nell’uomo e nella sua storia (contraddittoria, difficile, crudele e profonda) appare un attacco ben riuscito all’argilla di cui sono composti i piedi dei giganti del modernismo” e dell’implicito consumo.
In un certo senso, riscattando dalle complici penombre la pittura che conta – quella che si offre nuda all’osservatore e la nudità è l’abito degli Dei – meglio si apprezza un distinguo che, tra originario e originale tra memoria dell’oggetto e oggetto della memoria, ritorna alla vita sotto l’egida garbatamente cristallizzata vuoi della latina spes ultima dea vuoi della continuità di chi riaccarezza i vapori salubri e non chiassosi del decoro, poiché “la vita può essere compresa solo all’indietro, ma deve essere vissuta in avanti” (Kierkegaard).
Una premessa del genere mi pare quanto mai propedeutica per chiunque desideri accostarsi ad Esposito (partenopeo di casato, nicolaiano e barese di adozione, ma inevitabilmente greco nella quintessenza), esaminando i suoi esiti tutti navigati – dai primi Anni ’70 – sul mare limpidissimo della coerenza: una coerenza solare e ideale che ha consentito all’autore di volgere la vela sulle acque mai limacciose del nostro Rinascimento non solo tosco-romano (Giorgio Esposito si è formato alla scuola vegliarda di Enedina Zambrini Pinti discepola, nientemeno, di Giovanni Fattori), laddove, a sentire Sabino Jacobone in una nota del 1982, “l’arte si identificava con la scienza, cioè come scienza autonoma, soggetta a canoni e a leggi generali imprescindibili, governata da numeri e da ritmi geometrici ed architettonici rigorosi”.
Pertanto, come Paolo disarcionato sulla via che mena a Damasco, vien d’obbligo rivisitare, abbagliati dalle stesse folgori atemporali, “Pietro della Francesca, Leonardo, Durer, che profusero nelle loro opere tutta la perfezione della spazialità prospettica quattrocentesca”, mentre “non vi fu pittore dell’epoca che non avvertisse l’importanza – e, quindi, il rispetto – dei canoni e delle leggi, che governavano l’arte come scienza”, senza che una siffatta disciplina risultasse limitativa o, peggio ancora, riduttiva – anche per quegli artisti definibili, unicamente per assottigliamento filologico, minori – nei riguardi del dettato creativo e della sua gravida pratica. Rispetto, perciò, alla gran bagarre dello sperimentalismo tardo-novecentesco, Giorgio Esposito ha preferito l’antitesi all’allineamento, rivelandosi del mestiere logocentrico di pittore nello spiazzamento generazionale che legittimava persino la proteiforme moltiplicazione di schieramenti “che occultano, meglio tentano di occultare, dietro l’inconsistente schermo del nuovo, la loro limitatezza”.
Indispensabile, a tal fine, nel ventennale arco operativo di Esposito è stata e permane – punzonata a fuoco nella sua fibra – la pratica disegnativa in un processo di riverente e religioso avvicinamento ai carismi consigliati dall’età della Rinascenza, dai segreti affascinanti – ma sovente scomodi, al punto da rasentarne l’arcano – delle tecniche del tempo, all’idolatria del verbo dureriano, “con il suo ideale supremo: il corpo umano, cioè l’uomo, inteso come la più armoniosa, equilibrata e completa realtà vivente, fatta ad immagine di Dio”.
Ne è conferma tra una pleiade di disegni e di idee che santificano la sanguigna, quel particolare ductus che riorganizza in pianta l’imago senza improvvisare – ma ricostruendo secundum veritatem – le coordinate grafiche di una mappa del visibile, affinché non si smarrisca, investiti del grado di nocchieri di fronte alla rosa dei venti, la giusta rotta del tracciato.
È impossibile, perciò, non fermare il passo della nostra analisi su connotazioni critiche che definirei preliminari nella lettura di Giorgio Esposito: dall’abilità mimetica che trascina nel sogno elementare della rappresentazione -“dove rappresentazione (per dirla con Giorgio Colli) va intesa nel senso originario di un far riapparire di fronte: riapparire in prospettiva temporale” – alla virtuosa enfatizzazione del repertorio formale secondo una poetica che mira a ponderare la proporzione, contrapponendo alla teoria dell’eccesso il mentale riscatto del concetto di peso e di misura sulla superficie. Non a caso, la proporzione indicata da Gian Lorenzo Bernini al cavalier Freart de Chantelou era e resta “un aspetto del divino perché trae la sua origine dal corpo di Adamo, non solo modellato dalle mani di Dio, ma anche formato a sua immagine e somiglianza”: d’altra parte, l’archetipo – col suo spessore vieppiù tautologico – è scritto a grandi lettere nel libro della Genesi.
L’artisticità di Esposito, quindi, con le sue opzioni, con la sua museale tensione di “arte allo specchio” relata, di recente e senza convenevoli procedure, alla Nuova Maniera Italiana nonché ai suoi paradigmi storici e programmatici, mira soprattutto attraverso il disegno, ovvero “l’incipit della pittura” (D. Guzzi), ad adorare epifanicamente la verità della forma, penalizzandone le avverse ed altrui mistificazioni a pro’ di un’utile soliditas dell’immagine, adempiendo in tal senso, paladino di una crociata sempiterna allo scopo duale, ma univoco, del delectare e del docere.
Soltanto a queste condizioni si può entrare nei meandri del Tempo per affrontarlo con durlindane non donchisciottesche, perché da sempre il ruolo distruttore di Cronos per poter esistere ha bisogno proprio delle cose che va distruggendo. Così, l’assunto vale per Esposito, se l’uomo non originerà rovine attorno ai suoi passi potrà sopravvivere – fuori di lui – la memoria delle cose, quantunque sia palese come “il tempo non si ferma ad ammirare la gloria, se ne serve e passa oltre” (Chateubriand).
In questa concezione v’è, peraltro, una sorta di aderenza alla visione agostiniana che ci appare – tra i solchi dell’Hortus coltivato dal nostro autore – paludata coi nobili panni di un profeta michelangiolesco; un profeta messo a vedetta di nostra fiducia, guardiano di quanto potrebbe contare in perpetuo: il Gioele che allarga il manoscritto fino allo spasimo, l’Ezechiele che abbandona la sua scriptura voltandosi ad interrogarci, il Geremia che reclina lo sguardo e medita oltre i confini dell’umana ratio e di ogni lievitabile allegoria secondo la “nascosa veritade” dell’Alighieri.
Infatti, da profeta che non disdegna il ricorso ad una retorica insinuante, sia sub specie humanitatis sia sub specie aetemitatis, Esposito affronta pause discorsive, ma dichiarate con un rallentamento dimostrativo che tocca addirittura il diapason dell’ermetico, tanto da udire ad oltranza Salvator Rosa quando ammette che l’artista non deve dipingere “sol quel ch’è visibile/ma necessario è che talvolta additi/tutto quel ch’è incorporeo e ch’è possibile”. Tra l’altro, facendo ritorno alle ragioni di una scelta nel contempo etica ed estetica, s’è appurato con maggiore chiarezza come il pianeta artistico di Giorgio Esposito orbiti in una circonferenza concentrica a quella della classicità e dei conclamati Cinquecentisti, rispettando in fieri una traiettoria ereditaria e patrimoniale che autorizza – non mirando il passato dal monocolo delle citazioni d’apres – la disamina dell’avvenire.
In tal modo, nella teoria della compromissione che si evince dal diario pubblico e segreto di Esposito, medium incrollabile e unicistico riappare il sentimento della sapientia classica coi suoi referenti mai incongrui o sbavati. Lo dimostrano certi costrutti che rifuggono il moto centrifugo, abbracciando forme concluse con nettezza di taglio in una precipua scatola geometrica, ché la conquista dello spazio avviene all’interno di questa scatola per garantire la cosiddetta soluzione del gruppo: un problema che, nel tentativo di riproporre un dialogo convincente, ha appassionato i maestri dell’Ellenismo, ultimi eredi di un’arte di monologhi.
Precisiamo pure che per molti operatori d’oggi il classicismo è soprattutto una costante da viversi e da interiorizzare, per altri è un “ideale” la cui sommità, forse, è irraggiungibile, mentre per Esposito non è un accontentarsi della conoscenza selettiva di una tradizione, ma un possederla – con un’adesione palmare e sacralmente celebrativa – in maniera tangibile, ripercorrendo l’Antico sull’aura permanente dell’ispirazione senza le trappole vischiose della “moda” o dell’ovattato sconfinamento nell’adulazione. Guardare, invece, alle felici e loquacissime soluzioni dell’Antico significa imporsi una regola da seguire, accettandone a priori alcuni dettami e, tra questi, l’imitatio non più intesa sotto l’accezione di “limite”, bensì di “tonico”, in grado – a sua volta – di favorire il suo libero sviluppo delle arti.
L’artista, cioè, non deve guardare alla sola Natura, spesso “meschina”, ma deve rivolgere l’indice anche al contraltare dell’arte che ci ha preceduti.
Allorché, si è coscienti dei “prodotti” conseguiti dai Padri, la quaestio dell’imitazione, e Giorgio Esposito lo insegna, si traduce in libera scelta secondo quanto ammonisce la disciplina, con la sua triadicità severa di nome e di fatto: la semplicità sull’iter distintivo di un cartesiano nitore, l’euritmia da possedersi finanche con l’inganno della correzione ottica, la regolarità di un tracciato esemplare. Parliamo di un tracciato che, in Esposito, fa leva su un classicismo programmatico, una restaurazione intenzionale dei valori più coerenti della traditio cumulativamente antica, ma – ripeto – cinquecentesca nello specifico: uno specifico non dissimile dalla riforma dei Carracci o dal “Classicismo dell’Idea” predicato dal Domenichino mentre, dal suo pulpito, ci ricorda che il disegno “dà l’essere e non v’è niente che abbia forma fuor dai suoi termini”: un disegno, quindi, vasarianamente “padre delle tre arti […] idea e forma delle cose”. Per queste ragioni, la coscienza del Passato comporta altresì l’insorgenza della “Malinconia”: una ninfa inseguitrice della fluidità di tempo che, per contrappasso, marmorizza il mito e il miraggio dietro un velame quasi crepuscolare; indice di un isolamento sostanzialmente aristocratico, di un distacco individualista e letterario sull’orizzonte del saturnismo: “la mia allegrezza è la malinconia” (Michelangelo, sonetto LXXXI).
È una malinconia senza tempo, che sfida il “sembiante” dei volti eternati da Esposito con prassi fisiognometrica e notarile, mentre da un sentimento individuale si plana dolcemente verso l’astrazione di un sentimento universale: “il mondo è statua, immagine” esortava Tommaso Campanella. E’ la stessa malinconia che si attorciglia nel labirinto dell’acutezza, del “naturale ingegno” che vede – in un lampo che rischiara l’etere – le contraddizioni e le vicinanze tra le cose, traslandone infiniti significati “altri”.
È la constatazione “di un’irrimediabile solitudine, quella dell’artista, e dell’inneffabilità di un enigma più che millenario, quello dell’arte”; lo stesso enigma evocato in sospensione esclamativa da un passo della Vita Sacra di Marsilio Ficino: “quot sunt causae quibus literati melanchonici sint vel fiant”.
GAETANO MONGELLIn distacco individualista e letterario sull’orizzonte del saturnismo: “la mia allegrezza è la malinconia” (Michelangelo, sonetto LXXXI).
È una malinconia senza tempo, che sfida il “sembiante” dei volti eternati da Esposito con prassi fisiognometrica e notarile, mentre da un sentimento individuale si plana dolcemente verso l’astrazione di un sentimento universale: “il mondo è statua, immagine” esortava Tommaso Campanella. E’ la stessa malinconia che si attorciglia nel labirinto dell’acutezza, del “naturale ingegno” che vede – in un lampo che rischiara l’etere – le contraddizioni e le vicinanze tra le cose, traslandone infiniti significati “altri”.
È la constatazione “di un’irrimediabile solitudine, quella dell’artista, e dell’inneffabilità di un enigma più che millenario, quello dell’arte”; lo stesso enigma evocato in sospensione esclamativa da un passo della Vita Sacra di Marsilio Ficino: “quot sunt causae quibus literati melanchonici sint vel fiant”.
GAETANO MONGELLI





